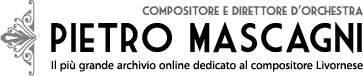Le donne di Mascagni
12 Gennaio 2014Le donne di Mascagni
L’universo mascagnano al femminile di Fulvio Venturi
“Dite, mamma Lucia… Turiddu ov’è?”
Diremmo che in questa domanda, con la quale si apre Cavalleria rusticana, vi è tutto il carattere
delle donne di Mascagni. La domanda è diretta e non ammette vie di fuga, ma è nondimeno presente una dolcezza, che non è la deferenza della donna giovane nei confronti della madre dell’uomo amato, ma è piuttosto naturale, endemica nell’indole del personaggio. E’ la dolcezza che ritroveremo nella preghiera, nel racconto “Voi lo sapete, o mamma”, in certi momenti della scena con Turiddu e soprattutto all’inizio del duetto con Alfio, nel fondamentale “Turiddu mi tolsel’onore”. E non è solo dolcezza.
Vi è l’orgoglio dell’amore ferito e tradito, la disperazione della donna che avverte di aver perduto il proprio uomo, la cupezza di un giorno senza sole, ovvero di una felicità che non si ritroverà più. E questi non sono sentimenti passivi, ma alimentati da un’estrema determinazione. Santuzza non è una che tace, che piange in silenzio. E’ una donna che denuncia, e non è mossa da desideri di vendetta, ma di giustizia. Poi vi è tutto un corredo d’emotività, d’istinto, una carica ed una forza vitale di assoluta rarità, ma diremmo che il carattere del personaggio di Santuzza è questo.
L’insieme di queste caratteristiche consegna al teatro d’opera un personaggio unico, lontano da ogni modello, nel quale riconosciamo più che in ogni altro i segnali di novità che appartengono a Cavalleria rusticana e ci induce a muovere dei passi di perlustrazione all’interno dell’universo femminile di Mascagni. Innanzitutto sorprende l’assenza quasi totale di grandi peccatrici, fatto assolutamente isolato nel mondo del melodramma. Su quindici titoli d’opera, tanti ne compongono il catalogo mascagnano, e su venti personaggi principali, le grandi peccatrici sono tre. In ordine cronologico: Matilde nel Silvano, Silvia nello Zanetto e Parisina. Matilde tradisce per necessità. Silvia, nell’obliato e spesso dileggiato Zanetto, è una cortigiana, e dunque rispetto alle peccatrici fedifraghe “fa sul suo”, ma bandisce l’amore dalla sua vita, riscattando la sua scelta e manifestando particolari ambitipsicologici sospesi fra patetismo e fatalità, rimpianto e desiderio di cambiamento; musicalmente anticipa qualcosa dei dibattimenti di Parisina, la fascinosa “traditora” dannunziana la quale, nel momento in cui è colta in flagrante peccato, difende l’amante addossandosi tutta la “colpa”, e rimettendoci la testa.
Vi sono poi delle donne che hanno conosciuto la vita, come la liberta Atte nel Nerone, o la protagonista dell’operetta Sì, ma che non si possono definire peccatrici tout-court. Niente in confronto delle Seselle, delle Cristine e delle Amalie, delle Malielle, di tutte le “buttane” che popoleranno contemporaneamente il mondo verista di A Santa Lucia (Pierantonio Tasca), di Mala vita! (Umberto Giordano), dei Gioielli della Madonnna (Wolf Ferrari), della sensuale e ribelle Nedda nei Pagliacci, della “disperata” Natalia nella Martire di Samaras e neanche quello più raffinato delle Manon Lescaut, di Magda nella Rondine, delle Fanny nella Sapho di Massenet.
Atte è un personaggio terribile e tragico che avverte la rivale in amore di “non danzare sull’orlo dell’abisso”. Parole quasi vaticinali perché quando Atte apparì sulla scena del tardivo Nerone si era nel 1935 e l’orlo dell’abisso sembra esattamente l’orribile voragine che stava per aprirsi sotto i piedi dell’umanità con la seconda guerra mondiale. E come una donna in guerra è spietata, sinistra. Non si prova simpatia per lei, ma è fedele fino alla morte.
Sì, invece, ha tutt’altra empatia con chi la frequenti. E’ una diva delle Folies-Bergère che si è conquistata sul campo delle avventure amorose il grazioso nomignolo che la contraddistingue. Non ha saputo mai dire di “no” e per questo è nota presso il démi-monde parigino. Si sposa per convenienza con un nobile, ma dopo il matrimonio scopre di essere innamorata del marito. Troppo tardi, lui ha una relazione con una donna del suo stesso lignaggio e scaccia Sì, che torna alla sua triste vita di palcoscenico. E’ un personaggino fragile, tipico del circondario operettistico, ma che sentimento e che languore. E’ anticonvenzionale e malinconica, forse troppo per essere inquadrata come semplice carattere operettistico, languida e quasi spettrale come le belle pagine che Mascagni le dedica. Siamo subito dopo prima guerra mondiale ed i suoi valzer malinconici, le sue rose sfiorite, segnano anche la fine di un’epoca.
Nel mondo di Mascagni le donne non si vendono per un pugno di gioielli, non si fanno mantenere, non fanno “la vita”. Piuttosto vi è tutta una galleria di vergini, di ragazze illibate, ingenue, vi è un mondo adolescenziale da difendere e da innalzare nel suo candore. Vi è un ideale nelle donne di Mascagni.
Subito dopo la tempesta emotiva di Santuzza, Mascagni dà vita ad un personaggio candido, Suzel nell’Amico Fritz, che porta mazzolini di fiori, cestini di ciliegie, che legge la Bibbia e che completa il proprio abbigliamento con un gran fiocco sulla testa. Una ragazza da sposare ante-litteram che tra rossori e ritrosie sa prendere l’uomo di cui è innamorata per mano e sa farsi dire da lui “ti amo” a sua volta. Più che con la questione morale siamo alle prese con la determinazione di cui prima si èfatto cenno. Suzel ha quasi una sorella in Luisa, il personaggio che anima I Rantzau, l’opera successiva all’Amico Fritz. In questo caso la determinazione non solo guida questo personaggio alla conquista dell’amore, ma anche al superamento di una diatriba familiare aspra ed annosa. Certo, Suzel e Luisa sono figlie non solo di uno stesso musicista, ma hanno in comune anche i padri letterari, gli scrittori Erckmann e Chatrian, ma è pur sempre stato Mascagni ad imprimere e dare risalto a quegli aspetti. La stessa tipologia vocale, che definiremmo virginale, ma con risvolti psicologici assai più turbati ed insondabili, appartiene anche a Maria, nel Guglielmo Ratcliff, opera che diremmo essere il palinsesto di tutto il Mascagni del primo periodo. Suzel, Luisa e Maria hanno tratti di nobiltà nella paternità letteraria data da Erckmann-Chatrian per le prime due e da Heine per la terza, ma riguardo il concetto di “donna ideale” mascagnana potremmo prendere ad esempio un personaggio di totale invenzione, Amica.
La sua anagrafe letteraria è sprovvista di nobili certificazioni paterne, e lei è così poco nobile da essere figlia di uno pseudonimo, Paul Bérel, che cela l’identità di un editore, Paul Choudens. Diremmo ironicamente, figlia illegittima della pura borghesia. Non che l’opera di cui questa ipotetica ragazza è protagonista sia un capolavoro, tutt’altro, ma il personaggio è veramente degno di nota in ragione della simbologia che porta con sé. Prima rifiuta di sposare l’uomo che potrebbe assicurarle un’esistenza tranquilla perché non l’ama, poi decide di fuggire verso vette innevate per non turbare l’equilibrio di due fratelli, ma soprattutto per vivere “plus près du ciel, plus loin de la terre, più presso al ciel, più lontan dalla terra”, ma trovando la morte. Amica è dunque sinonimo di libertà, di una libertà da difendere addirittura con la vita. Un ideale d’amore e di giustizia anima anche Mariella nel Piccolo Marat, fino al punto in cui, una volta perseguita tale causa, nel finale dell’opera, Mascagni libera undispiegamento sinfonico tanto lucente da far ipotizzare il sorgere del Sole dell’Avvenire.
L’infanzia negata, l’adolescenza violata, l’elusione di ogni diritto femminile sono invece alla base della favola nera di Iris di cui è bene, in questa occasione, ricordare la trama. In un villaggio ai piedi del Fujiyama vive Iris dedicandosi completamente ad accudire il padre cieco. Iris, adolescente ingenua ed illibata, è anche molto bella e di lei s’invaghisce un giovane ricco ed annoiato che sfogala propria ansia esistenziale nell’erotismo, Osaka, il quale con l’aiuto di un lenone, Kyoto, la fa rapire. I due inviano Iris al Yoshiwara, il quartiere dei piaceri e lasciano uno scritto con del denaro al Cieco facendo intendere che Iris si è venduta volontariamente. Nella casa di piacere di Kyoto al Yoshiwara Osaka tenta di sedurre Iris con vesti e gioielli, e si rivolge alla ragazza con un linguaggio pervaso di sottili allusioni amorose, ma tutto è invano. Iris non capisce. Allora tenta una via di seduzione più diretta, dicendo alla ragazza che egli stesso è il piacere fatto persona. Iris lo respinge. In quel momento sopraggiunge il Cieco che si è fatto guidare fin là ed offende la figlia lanciandolecontro manciate di fango. Iris, disperata, si getta da un balcone e finisce in un dirupo. In quel dirupo, una discarica popolata da rag-pickers che ne seviziano il corpo per spogliarlo delle vesti preziose di cui era stato abbigliato nella casa di piacere, Iris, dopo aver trascorso una notte in agonia, muore al sorgere del giorno domandandosi il perché di tutta la vicenda, mentre un raggio di sole la illumina, facendola salire a Nirvana.
Il Giappone non c’entra, così come è completamente superato il “verismo” legato a situazioni contingenti. Iris è l’ideale della purezza, e gli uomini che la circondano, dall’egoismo del padre (simbolicamente “cieco”), al perverso desiderio di Osaka, dal cinismo di Kyoto, alla brutale indifferenza dei cenciaiuoli, la violentano, la feriscono nell’anima e nel corpo, la uccidono con atroce egoismo abbandonandone il corpo in un immondezzaio. Straordinario documento di denuncia sociale che giunge nel momento in cui l’Italia premia con una medaglia le cannonate di Bava Beccaris sulle prime dimostrazioni operaie.
Non esiste un personaggio parallelo ad Iris in tutto il mondo del melodramma, neppure nei sottili dualismi di Venere creati da Puccini, così come “unico” nella sua ammantata purezza, che non è quella gelida di Turandot, bensì quella stilnovistica di Guinizelli con la diatriba trobadorica sui concetti d’amore, è quello d’Isabeau. Non tragga in inganno la popolare leggenda inglese di Godiva che, cantata dalla ballade omonima di Alfred Tennyson, è alla base del plot di Illica riguardo quest’opera. Sì, certo, vi è uno slancio verso i sudditi, ma Isabeau ha soprattutto dei “misteri biondi” da preservare immuni dalla ragion di stato paterna e dalle tentazioni carnali.
Facendo un passo indietro per tornare alla giovinezza di Mascagni, troviamo un personaggio assolutamente indimenticabile, nella “pazza” Margherita del Guglielmo Ratcliff. Pietrificata nel suo estremo dolore che l’ha consegnata ad un sopore continuo, animato da fantasmi, da mani insanguinate che reiterano il delitto, è lei che detiene la verità, e che trova pace solo nella catarsi.
Sicuramente questo personaggio appartiene al padre letterario, che è Heinrich Heine, ma è altrettanto certo che lo “spirto guerriero” del giovane Mascagni trovasse ispirazione entusiastica e visionaria in quel carattere. La pazza Margherita con la sua nobile progenie letteraria, e con la sua tipologia vocale, stabilisce poi un contatto con la non meno memorabile Stella dell’Assissino di Parisina. “Mater dolorosa” di grandiosa statura teatrale a quest’ultimo personaggio Mascagni destina pagine impetuose in totale connubio con la forza espressiva della parola.
Magnifico caleidoscopio di sensazioni e sentimenti, infine, il mondo femminile di Mascagni vive anche delle suggestioni poetiche e pittoriche che lo circondarono. Impossibile pensare a Santuzza senza immaginare le contadine in processione di Cristiano Banti e certi visioni pomeridiane di Telemaco Signorini riarse di luce e di sabbie. Molto più della scabra e fin troppo asciutta novella di Verga, e della conseguente pièce teatrale, che dà origine al plot, ma non ai sentimenti di Cavalleria, così come l’intimismo dell’Amico Fritz e dei Rantzau, con le tenerezze di Suzel ed i solipsismi di Luisa, pare più figlio della pittura d’interni di Fattori, Lega, Cecioni e Cannicci, di certe ombreggiature di Borrani, forse anche della poesia di Marradi (“Io sono un giovin cavaliere errante/ che in selve ignote e scure/ cerco avventure” non è forse il “BelCavaliere che vai per la foresta” di Suzel ed il triste “Perché una cupa, inesorata, immane/ malinconia sul mio cervel piombò” non si affianca all’assorto “Fa che i pensier non tornino” di Luisa Rantzau?) che non della prosa un po’ monotona (così la definì Zola) e manierata di Erckmann-Chatrian.
Così le ansie di Matilde sono calate, come tutto Silvano, nelle liquide atmosfere marine di Plinio Nomellini e nella variegata tavolozza timbrica di certi paesaggisti meridionali come Giuseppe Casciaro. Plinio Nomellini, poi, scenderà in campo personalmente con la creazione del manifesto di Parisina, effigie che sintetizza con singolare capacità lo spirito endemico di tale lavoro.
Iris, sublime ikebana, si muove in parallelo con la gestazione della più affascinante creatura poetica dannunziana, Alcyone, con i suoi mari claustrali, immobili (“E il cielo è nivale/ come su la tua guancia/ ondata il velo/ insolito./ Il mare è d’opale/ con vene di crisòlito,/ come i mari dell’Asia,/ immoto albore/ di gemme fuse/ Brillano le meduse/ a fiore/ dell’immerso banco.”) dai quali emergono creature di piacere e di morte, come le piovre tentacolari che escono dalla “plaga/ d’un gran mare morto/ color del bronzo” dell’opera mascagnana. Questo non comune documento culturale vive inoltre di tutta un’iconografia che facendo capo ai mantra di Hokusai, giunge fino ad oggi (l’ultima produzione firmata da Federico Tiezzi e dallo staff del teatro livornese) varcando le volute decadenti di Hohenstein e le acque stagnanti di Monet.
Uno stesso spirito dannunziano, e in questo caso addirittura antecedente ad Alcyone, alberga nei tratti tragicamente statici di Atte come in quelli ripiegati e mortuari di Nerone. Non sorprenda la data di quest’opera, che è 1935. Mascagni nella composizione di questa suo ultimo lavoro attinse ai materiali inultimati di Vistilia, risalenti al periodo situato tra il 1894 ed il 1900. Così i versi della Naiade (“Morta è Selene; morte son le Argire;/ i talami, deserti; nel sovrano/ silenzio de la notte l’acqua tace;/ ma pur sembrami a quando a quando udire/ il gorgoglio di un’urna che una mano/invisibile affonda in quella pace.”) tratti dal Poema paradisiaco di D’Annunzio (1893), con il loro soffocato bisbigliare ed il senso del ricordo e del rimpianto, potrebbero sostituire quelli dell’entrata di Atte ed un quadro di Giulio Bargellini, l’Alma Tadema italiano, costituire l’intera iconografia di Nerone.
Fulvio Venturi
Giugno 2013